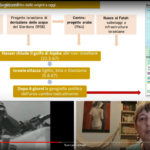“Welcome to Giovanni Paolo II and president Yasser Arafat”. La grande scritta è ancora lì e accoglie chiunque si affacci in Manger Square. Nelle polverose vetrine delle rare botteghe aperte sono ammassati i souvenir prodotti per il Giubileo e rimasti invenduti. Nei bar sono appesi calendari ormai sbiaditi dell’anno 2000, come se contare i giorni e i mesi non avesse più alcun senso.A Betlemme il tempo sembra essersi fermato a quell’estate del 2000 quando la pace sembrava ancora possibile.
“Non puoi immaginare cos’era questa piazza tre anni fa. La gente stava in coda per ore prima di poter entrare nella Basilica”, dice William, il guardiano della chiesa di S.Caterina a Betlemme mentre, uniche visitatrici della giornata, accompagna me e Anna nel chiostro del convento francescano.
Le ferite più profonde sono state curate. Dalla piazza sono quasi del tutto spariti i segni lasciati dai proiettili; nelle vie adiacenti, il selciato distrutto dai carri armati è tornato liscio e levigato, le case bombardate sono state ricostruite. Nel centro di Betlemme non ci sono quasi più tracce della furiosa battaglia che si è combattuta per le strade della città nella primavera del 2002 e che ha avuto il suo tragico epilogo nell’assedio alla Basilica della Natività durato 39 giorni. Il ricordo più evidente di quei giorni è l’ammasso di macerie della sede dell’Autorità Palestinese fatta esplodere dall’esercito israeliano.
È però proprio questa apparente normalità che rende ancora più surreale, per uno straniero, camminare per le strade di questa città. Quando Muhammed mi presenta ai numerosi amici che incontriamo, spiegando che sono una turista, i volti si aprono in grandi sorrisi e, stringendomi la mano, anziani signori con la kefiah, giovani ragazzi dall’espressione furba, gentili signore con il capo coperto mi ripetono: “Shukran, shukran”.
Nelle settimane successive finirò con l’abituarmi a questa imbarazzante riconoscenza, ma i primi giorni mi sembra di essere la protagonista dello spot pubblicitario che imperversa sulle nostre TV, dove tutti ringraziano un ignaro acquirente per il solo fatto che ha comprato qualcosa.
Indice degli argomenti
PERCORSO A OSTACOLI
Muhammed vive in un villaggio di 6000 abitanti distante meno di 10 chilometri da Betlemme: vicino secondo i parametri italiani, lontanissimo in base a quelli palestinesi.
Betlemme è in zona A e quindi si trova sotto il completo controllo dell’Autorità Palestinese (alla quale la città è stata riconsegnata lo scorso 2 luglio); il villaggio è in zona B, in questo caso l’Autorità sarebbe responsabile di garantire l’ordine pubblico per quanto riguarda i palestinesi e Israele dovrebbe mantenere il controllo della sicurezza, in pratica l’unica presenza è quella dell’esercito israeliano.
Tra Betlemme e il villaggio passa una delle tante strade “by-pass” che collegano i diversi insediamenti dei coloni e che non sono percorribili dalle auto palestinesi; la strada si trova in zona C che, secondo gli accordi di Oslo, è sotto il controllo civile e militare israeliano e soggetta a negoziato (nella cartina fornitami dall’ufficio turistico israeliano in Italia, però, la zona C è sparita e tutta quest’area – circa il 59 per cento della Cisgiordania – appare come territorio di Israele).
Che vivano della vendita dei loro prodotti agricoli, che lavorino negli uffici, nelle officine o nei negozi di Betlemme, che vadano in Israele a costruire case (quello del muratore è ormai l’unico lavoro che, quando è possibile, i palestinesi riescono a esercitare in Israele perché negli altri sono stati soppiantati dal milione e mezzo di ebrei immigrati dall’Europa Orientale) gli abitanti del villaggio devono passare dal check point di El Khadr.
Si sale sul taxi nella piazza del villaggio e, percorsi circa 8 chilometri, si arriva in prossimità della strada israeliana. Per impedire alle auto di proseguire, gli israeliani hanno distrutto una decina di metri di strada e creato uno sbarramento di terra e cemento, quindi tutti giù e breve tratto a piedi di circa 300 metri. Superata la strada israeliana e uno sbarramento analogo al precedente si giunge allo spiazzo, trasformato in un piccolo suq, nel quale è possibile prendere il taxi o l’autobus per compiere gli ultimi 2 chilometri verso il centro di Betlemme. In totale non meno di 1 ora per percorrere circa 10 chilometri.
Difficile credere che la sicurezza sia lo scopo principale di questo percorso ad ostacoli: nessun soldato presidia normalmente El Khadr. “Dopo gli accordi di Oslo e prima della seconda Intifada potevamo muoverci con molta più facilità. Potevo andare addirittura a Tel Aviv o a Gerusalemme”, mi dice Muhammed con una voce incredula, quasi non credesse alle sue stesse parole.
IL COPRIFUOCO
La capacità dell’essere umano di adattarsi è sorprendente e dopo qualche giorno mi abituo alla quotidiana gincana, ma il ferimento di alcuni coloni nel vicino insediamento di Har Gillo fa scattare il coprifuoco. Un coprifuoco “leggero”, come lo chiamano i palestinesi, di quelli che non sono neanche menzionati nelle cronache dei giornali internazionali. La motivazione, naturalmente, è quella della sicurezza, in realtà si può fare esattamente tutto quello che si faceva fino al giorno prima: solo che è molto più faticoso e complicato.
El Khadr viene chiuso e si passa da Efrata. La differenza è che bisogna prendere un mezzo in più, questa volta però si tratta di taxi israeliani che possono percorrere i 4 chilometri di strada “by-pass” fino al punto di collegamento con la strada per il villaggio, giunti al quale è necessario camminare per più di un chilometro e superare i soliti sbarramenti prima di raggiungere il luogo dove possono arrivare i taxi che finalmente conducono a casa. Il primo giorno di coprifuoco, al check point di Efrata i soldati israeliani ci sono, ma fermano solo alcuni dei palestinesi che transitano, mentre altri passano senza che venga chiesto loro nulla. Mi chiedo qual è il criterio che regola questi controlli, ma la domanda rimane senza risposta e si insinua il dubbio che servano più per umiliare i palestinesi che per proteggere gli israeliani.
Il giorno successivo, però, la musica è completamente diversa. Giunta ad Efrata mi sembra di essere arrivata su un set cinematografico. Uno di quelli sulla seconda guerra mondiale dove i nazisti hanno un aspetto talmente feroce e urlano ordini a una folla impaurita che ti viene da pensare che il regista abbia un tantino esagerato.
Intorno alle due camionette dell’esercito ci sono 5 o 6 soldati e uno di questi, un ragazzo che non sembra avere più di vent’anni, puntando il mitra sui vecchi, i ragazzi, gli uomini e le donne in attesa, urla di avanzare quattro per volta. Chi non rispetta l’ordine viene spintonato indietro con la punta del mitra. Questa volta i documenti vengono controllati uno ad uno e quando giunge il mio turno (che non sarebbe mai arrivato se un ragazzo palestinese non mi avesse sospinto in avanti dato che io, paralizzata dalla paura, non osavo avanzare), il soldato guarda rapidamente il passaporto italiano e mi congeda con un: “Shalom. Have a good trip”. Mi sale alle labbra una risposta tutt’altro che pacifica, ma temo sia troppo internazionale e possa essere compresa anche da chi non sa una parola di italiano. Meglio lasciar perdere.
Passato il controllo, un’altra spiacevole sorpresa: i soldati hanno mandato via i taxi in attesa e quindi bisogna percorrere a piedi i 4 chilometri della strada “by-pass”. Le auto sfrecciano veloci (si tratta di una specie di superstrada) e mentre camminiamo sulla corsia di emergenza un’auto si dirige verso di noi a tutta velocità, io faccio un balzo oltre il guardrail ma il ragazzo che mi aveva aiutato poco prima al posto di blocco mi trattiene e sorridendo dice: “Don’t worry it’s a joke of the settlers” (non ti preoccupare, è uno gioco dei coloni). E in effetti la macchina ci scarta all’ultimo secondo, alcuni ragazzi incominciano a cantare; non riesco a trattenermi e seguo il loro esempio intonando la prima canzone che mi viene in mente (e che mai mi è sembrata più appropriata), Bella Ciao, imponendo così ai miei giovani compagni di viaggio anche il supplizio del mio canto. Quando alla fine arriviamo a casa, Muhammed, dopo avere ascoltato il nostro racconto, con il suo sorriso ironico, velato da una profonda tristezza, dice: “Dopo il ’48 volevamo la distruzione di Israele, dopo il ’67 chiedevamo l’autonomia dei territori, adesso basterebbe ci riaprissero la strada per Betlemme”.
IL VILLAGGIO
Muhammed, insieme ad alcuni amici, ha aperto nel villaggio un Centro culturale nel quale si tengono corsi di informatica e le cui aule sono messe a disposizione degli studenti del paese che necessitano di lezioni di sostegno. Tra i sostenitori del Centro c’è anche una piccola associazione italiana, Micromondo, che ha attrezzato una delle aule e finanziato un corso di informatica per 70 ragazzi. “Il Centro consente a bambini e ragazzi, per i quali sarebbe altrimenti impossibile, di avvicinarsi all’informatica, imparare le nozioni di base. E poi la sera diventa anche un luogo di incontro: i ragazzi del villaggio così stanno lontani dalla strada, possono collegarsi a Internet e rimanere in contatto con un mondo che, per noi, chiude le porte alle 7 di sera quando non è praticamente più possibile uscire dal paese”, dice Muhammad.
Ma il Centro non serve solo ai giovani. Mentre chiacchieriamo si presenta un’anziana coppia che, dopo un rapido saluto, si avvicina a uno dei computer liberi; la signora indossa la cuffia e, dopo poco, ride parlando al microfono. Muhammad risponde al mio sguardo interrogativo: “Il figlio studia all’estero e una volta alla settimana si danno appuntamento. Costa molto meno che telefonare e con la web cam si possono anche vedere”.
La difficoltà a muoversi è una delle frustrazioni che i più giovani sentono maggiormente. Samir, studente universitario di economia, ha sempre fatto qualche lavoro per mantenersi e nel 2000 era baby sitter presso una famiglia ebrea di Gerusalemme. Con l’inizio dell’Intifada e il divieto per i palestinesi ad andare a Gerusalemme se non provvisti di un particolare permesso (difficilissimo da ottenere e quasi impossibile per gli uomini al di sotto dei 45 anni), ha dovuto abbandonare il posto con reciproco rammarico, suo e della famiglia: “Anche adesso ci sentiamo spesso e quando sanno che da noi ci sono dei problemi, mi chiamano sempre. Ma come faccio ad andarli a trovare? Non posso proprio”. A Samir piacerebbe molto viaggiare.
Il condizionale è d’obbligo perché, oltre alle difficoltà economiche, per un palestinese è piuttosto complicato andare all’estero. Non potendo, in pratica, utilizzare l’aeroporto di Tel Aviv, gli abitanti della Cisgiordania devono partire da Amman e questo, soprattutto dopo la seconda Intifada, comporta lunghe attese (anche di due o tre giorni) alla frontiera con la Giordania. Se poi si intende andare in un paese che richiede il visto, la questione è ancora più complessa dato che ambasciate e rappresentanze consolari sono a Tel Aviv o a Gerusalemme.
I VICINI
L’art. 31 degli accordi di Oslo stabiliva il mantenimento dello status quo in Cisgiordania e Gaza fino alla definizione dello status definitivo. Fino al 1993, data degli accordi, i coloni in Cisgiordania (esclusa Gerusalemme Est) e Gaza erano circa 110mila, allo scoppio della seconda Infifada, nel settembre 2000, erano saliti a 170mila.
Da qualsiasi punto del villaggio è ben visibile l’insediamento di coloni che si trova sulla collina di fronte. Fino al 1987 c’era un appostamento militare, quando l’esercito se ne è andato ha lasciato il posto ad alcuni caravan di civili, poi sono state costruite le prime case e oggi è un paese che occupa tutta la collina. Mentre Muhammad mi spiega che questo è il tipico modo in cui ha inizio un insediamento, una domanda mi sorge spontanea: “Ma scusa, se sapete che funziona così, perché non iniziate a protestare appena arrivano con i caravan?”
Dall’espressione con cui mi guarda, capisco che il mio amico si sta chiedendo da quale pianeta arrivo, ma pazientemente mi risponde: “Certo che a volte protestiamo subito, facciamo anche ricorso alla corte di giustizia. Intanto quelli vanno avanti. Magari la corte ci dà anche ragione, ma nel frattempo le case sono state costruite e allora è molto, molto difficile che l’esercito israeliano intervenga per buttarle giù”.
Tanto perché io capisca più chiaramente come stanno le cose, mi racconta un altro episodio. Quando l’insediamento ha iniziato a espandersi sono state naturalmente costruite le fogne, il cui scarico è stato fatto sfociare nell’avvallamento sottostante, direttamente sulle terre coltivate dagli abitanti del villaggio. Questi hanno immediatamente presentato una protesta alla corte di giustizia che ha dato loro ragione e obbligato l’insediamento a costruire un depuratore. Penso che, allora, un minimo di legalità c’è! Muhammad sembra avermi letto nel pensiero perché aggiunge che la corte, però, ha dato all’insediamento sei anni di tempo per costruire il depuratore; nel frattempo, ovviamente, le terre sono diventate inutilizzabili.
UNA VITA NORMALE
Maher mi chiede qual è il mio gruppo musicale preferito. Mi parla di gruppi rock che non ho mai sentito, ma la differenza di età è troppo grande perché i nostri gusti musicali si incontrino.
Alla fine troviamo un punto di contatto su Bruce Springsteen.
Intizar, che studia ingegneria informatica, mi chiede qualche informazione sul linguaggio Java.
Rola mi mostra con orgoglio le aule e i laboratori dell’università.
Sono ragazzi di 20-22 anni e quando faccio loro domande sulla situazione politica o sul processo di pace mi rispondono con cortesia, cercano le parole per trasmettermi un messaggio di speranza: non vogliono deludermi, ma è evidente che quella speranza, per loro, è sepolta da tempo e si torna a parlare di musica, di libri, di viaggi perché così, per la breve durata del nostro incontro, possono pensare di essere persone normali, che fanno una vita normale.